Elisabetta Zendri - Presidente
Tel.: 041 234 6730
E-mail: elizen@unive.it
Università Ca’ Foscari di Venezia
Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica
Via Torino 155, 30172 Mestre – Venezia

Benvenuti nelle pagine della Divisione di Chimica dell'Ambiente e dei Beni Culturali
La Divisione è la comunità scientifica di riferimento per tutti coloro che, a vario titolo, si occupano di chimica dell'ambiente e dei beni culturali.
La Divisione favorisce la diffusione ed il potenziamento degli aspetti scientifici, tecnologici e didattici di tale disciplina mediante pubblicazioni scientifiche, l’organizzazione di congressi e scuole, corsi di aggiornamento, gruppi di studio e altre iniziative, anche in collegamento con altri Enti ed Imprese, Società Scientifiche (e.g. EuChemS) ed Accademie di riconosciuto prestigio a livello internazionale.
Forte di una solida base scientifica e di un’identità culturale ben definita, la Divisione affronta temi centrali nelle principali sfide, da quelle locali a quelle globali, riguardanti la salvaguardia dell’ambiente e dei beni culturali, quali:
- la chimica e la reattività di contaminanti e inquinanti nell’ambiente e nei beni culturali;
- lo sviluppo e l’utilizzo di metodi diagnostici per la caratterizzazione di manufatti storici, artistici e archeologici;
- la valutazione della sostenibilità, degli impatti e dei rischi ambientali;
- le cause e gli effetti del cambiamento climatico sull’ambiente e sui beni culturali;
- la valutazione e l’implementazione della sostenibilità sull’intero ciclo di vita di sostanze e materiali per la conservazione del patrimonio culturale e il risanamento ambientale;
- il monitoraggio della qualità ambientale e dello stato di conservazione dei beni culturali.
La Divisione di Chimica Ambientale venne costituita all’interno della Società Chimica Italiana nel 1994. Le sue radici derivavano dal Gruppo Interdivisionale di Chimica dell’Ambiente i cui soci promossero l’iniziativa. Il Congresso costitutivo della Divisione fu tenuto a Roma nell’ottobre 1994 e il primo Presidente eletto della Divisione dal 1995 al 1997 fu Ottavio Tubertini. Nel 2004, considerati i comuni interessi, la Divisione di Chimica Ambientale e il Gruppo Interdivisionale di Chimica dei Beni Culturali (ChiBeC) diedero vita alla Divisione di Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali, il cui primo Presidente eletto fu Luigi Campanella.
Direttivo

Presidente Elisabetta Zendri
Università Ca’ Foscari di Venezia
Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica
Via Torino 155, 30172 Mestre – Venezia
Tel.: 041 234 6730
E-mail: elizen@unive.it

Vicepresidente Raffaele Cucciniello
Università di Salerno
Dipartimento di Chimica e Biologia “Adolfo Zambelli”
Via Giovanni Paolo II 132, 84084 Fisciano (SA), Italy
Tel: 089 96 9575
E-mail: rcucciniello@unisa.it

Segretario Marco Malagodi
Università di Pavia
Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali
Corso Garibaldi 178, 26100 Cremona
Tel: 0372 567770; 0372 25575
E-mail: marco.malagodi@unipv.it

Tesoriere Giorgia Sciutto
Università di Bologna
Dipartimento di Chimica “Giacomo Ciamician”
Via Gobetti 85, Bologna
Tel: 0544 937155
E-mail: giorgia.sciutto@unibo.it

Past-president Antonio Proto
Università di Salerno
Dipartimento di Chimica e Biologia “Adolfo Zambelli”
Via Giovanni Paolo II 132, 84084 Fisciano (SA), Italy
Tel: 089 96 9581 – Fax: 089 96 9603
E-mail: aproto@unisa.it

Consigliere Daniele Cespi
Università di Bologna
Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari”
Via Piero Gobetti 85, Bologna
Tel: 051 20 93131
E-mail: daniele.cespi2@unibo.it

Consigliere Elena Chianese
Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Centro Direzionale, isola C4 – 80143 Napoli
E-mail: elena.chianese@uniparthenope.it

Consigliere Davide Vione
Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Chimica
Via Pietro Giuria 5 – 10125, Torino
Tel: 011 6705296; Fax 011 6705242
E-mail: davide.vione@unito.it
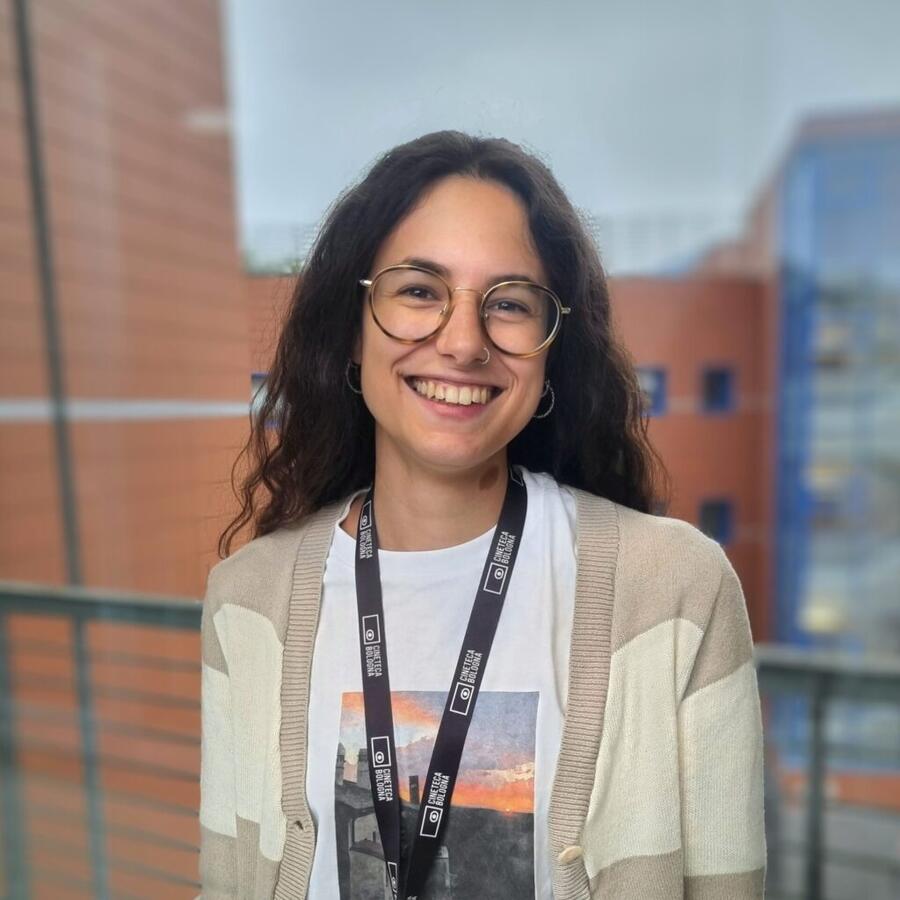
Consigliere Eleonora Rossi
Università di Bologna
Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari”
Viale del Risorgimento 4, Bologna
E-mail: eleonora.rossi51@unibo.it
Documenti
Notizie
Congressi

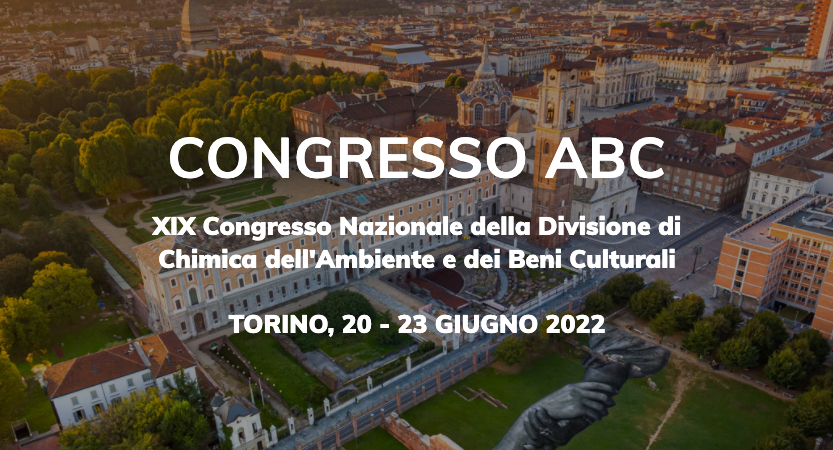
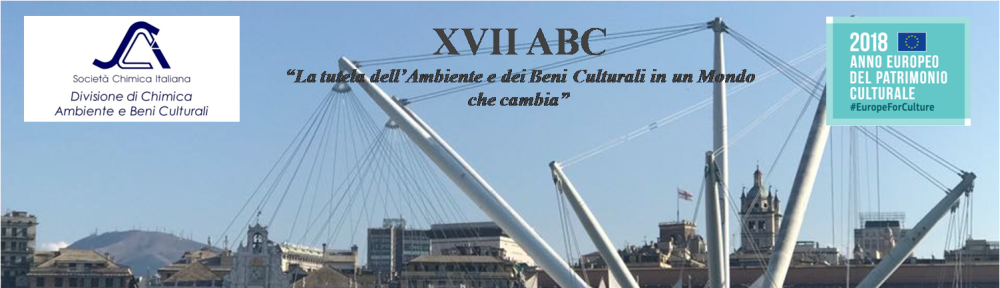
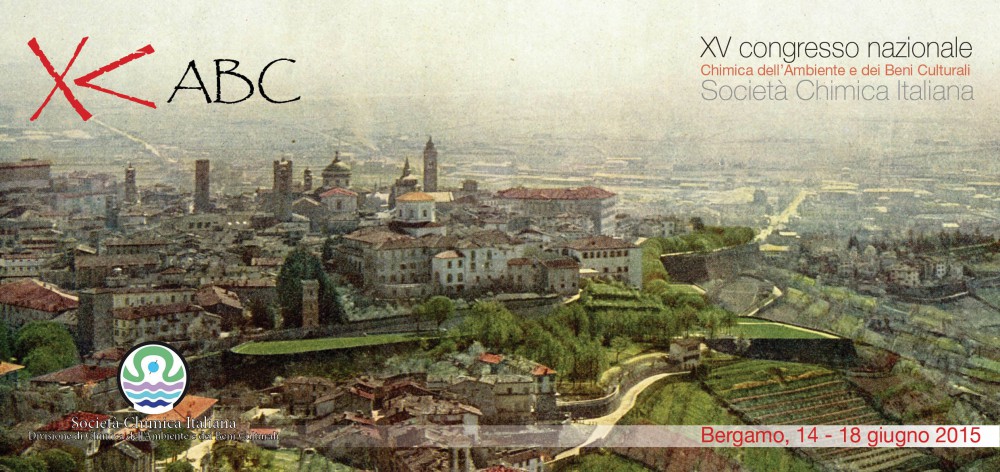

Scuole



Premi e medaglie
Premi e medaglie
Medaglia “D.H. Meadows & R.L. Feller”
Con la medaglia “D.H. Meadows & R.L. Feller”, la Divisione di Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali della Società Chimica Italiana intende conferire un solenne riconoscimento a studiosi che si siano distinti a livello nazionale ed internazionale per la loro attività di ricerca negli ambiti culturali identitari della Divisione di Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali.
L’assegnazione del premio, con la lettura delle motivazioni, avverrà in occasione del Congresso Nazionale o di qualunque altro convegno o evento organizzato dalla Divisione di Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali.
Le candidature devono essere presentate al Presidente della Divisione di Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali, entro i termini indicati nel bando, da 3 soci effettivi della Divisione di Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali della Società Chimica Italiana.
Donella (“Dana”) Hager Meadows (13 marzo 1941 – 20 febbraio 2001) fu una scienziata ambientale, nonché educatrice e scrittrice. Si formò in chimica (B.A. presso il Carleton College nel 1963) e conseguì poi il dottorato in biofisica (Harvard, 1968), dimostrando da subito una chiara propensione alla interdisciplinarietà. Insegnò per 29 anni, iniziando nel 1972, presso l’Università “Dartmouth College” nel New Hampshire. Ricercatrice al Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston, ha gettato le basi dello studio dello sviluppo sostenibile con intuizioni pionieristiche, come quelle contenute nel noto rapporto del Club di Roma "The limits to growth" del 1972 (di cui è la prima autrice). In aggiunta, ha anche cercato di vivere e di favorire a liv ello sociale una crescita della consapevolezza attorno a questa prospettiva. Giornalista pluripremiata e divulgatrice, fondatrice dell'INRIC (International Network of Resource Information Centers) che riunisce analisti e attivisti di 50 nazioni, impegnati nella promozione di una gestione sostenibile delle risorse, ha vissuto per 27 anni in una piccola fattoria biologica nel New Hampshire, lavorando direttamente sulla gestione sostenibile delle risorse. Nel 1999 si trasferì nel Vermont dove fondò un eco-villaggio, gestendo anche una fattoria biologica dove stabilì la sede del Sustainability Institute (fondato nel 1996), il quale riunisce l'attenta ricerca sui sistemi globali con la dimostrazione pratica di una vita sostenibile. Morì dopo una breve malattia a soli 59 anni.
Robert L. Feller (1920-2018). Nato a Linden, N.J., Feller amava l'arte da giovane e spesso dipingeva e disegnava. Ha intrapreso una carriera scientifica perché sentiva di non poter vivere in modo sostenibile come
artista. Dopo aver completato il suo dottorato di ricerca, nel 1950, in chimica-fisica organica presso la Rutgers University, Feller si è impegnato nella ricerca sui problemi legati alla conservazione, inizialmente come ricercatore senior della National Gallery of Art di Washington e, successivamente (1997), come primo direttore fondatore
del Research Center on the Materials of the Artist and Conservator presso il Mellon Institute (ora Carnegie Mellon Research Institute), a Pittsburgh. Durante l'alluvione di Firenze del 1966, Feller operò come consulente, aiutando gli ambientalisti a salvare alcune delle opere d'arte rinascimentali più importanti del mondo. Dopo il pensionamento, nel 1988, è stato direttore emerito del Centro Ricerche. Al Centro di ricerca sui materiali Carnegie Mellon Institute, Feller ha studiato polimeri, pigmenti, composti organici naturali e vernici, al fine di trovare modi per preservare e riparare le opere d'arte. Ha pubblicato più di 130 articoli e capitoli in libri. Il suo contributo all'invecchiamento dei materiali pittorici (pigmenti, leganti e vernici) e alla fotochimica dello sbiadimento del colore nei dipinti riveste un'importanza fondamentale per generazioni di scienziati della conservazione.
Medaglia “Mario Molina”
Con la medaglia “Mario Molina”, la Divisione di Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali della Società Chimica Italiana (da qui in avanti, "Divisione") intende conferire un riconoscimento a giovani studiosi di età inferiore a 40 anni, soci effettivi della Divisione da almeno 2 anni, i quali si siano già distinti per l‘eccellenza della loro attività di ricerca nel settore della Chimica dell'Ambiente. La medaglia è assegnata in occasione del Congresso Divisionale.
Mario Molina (1943-2020) ha conseguito la laurea in Ingegneria Chimica (1965) presso l'Universidad Nacional Autónoma de México e un dottorato di ricerca in Chimica Fisica (1972) presso l'Università della California a Berkeley. Fu un pioniere e uno dei principali scienziati al mondo a dedicarsi alla chimica dell'atmosfera. È stato coautore con Frank Sherwood Rowland dell'articolo originale del 1974 che prevedeva l'esaurimento dello strato di ozono come diretta conseguenza delle emissioni di alcuni gas industriali, i clorofluorocarburi (CFC), guadagnandosi nel 1995 il Premio Nobel per la Chimica. Allo stesso modo, le sue ricerche e pubblicazioni sull'argomento hanno portato al Protocollo di Montreal delle Nazioni Unite, il primo trattato internazionale che ha affrontato con efficacia un problema ambientale di scala globale e di origine antropica. Il professor Molina e il suo gruppo diricerca hanno pubblicato una serie di articoli, tra il 1976 e il 1986, i quali hanno identificato le proprietà chimiche dei composti che svolgono un ruolo essenziale nella degradazione dello strato di ozono stratosferico. Successivamente, essi hanno dimostrato in laboratorio l'esistenza di una nuova classe di reazioni chimiche che avvengono sulla superficie delle particelle di ghiaccio, comprese quelle presenti nell'atmosfera. Hanno anche proposto e dimostrato in laboratorio una nuova sequenza di reazioni catalitiche che spiegano gran parte della distruzione dell'ozono nella stratosfera polare.
Molina è stato Professore d'Istituto presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT) dal 1989 al 2004; ha altresì
svolto incarichi di ricerca e insegnamento presso l'Universidad Autónoma de México tra il 1967 e il 1968, presso l'Università della California a Irvine tra il 1975 e il 1979, nonché presso il Jet Propulsion Laboratory del California Institute of Technology (Caltech) tra il 1982 e il 1989. È stato membro della National Academy of Sciences e dell'Institute of Medicine negli Stati Uniti e, per otto anni, è stato uno dei 21 scienziati che hanno prestato servizio nel
Comitato dei consulenti per la scienza e la tecnologia (PCAST) del presidente Barack Obama; in precedenza, ha anche prestato servizio nel PCAST del presidente Bill Clinton. Allo stesso modo è stato un illustre membro, tra gli altri, della Pontificia Accademia delle Scienze del Vaticano, del Collegio Nazionale del Messico, dell'Accademia Messicana delle Scienze e dell'Accademia Messicana di Ingegneria. Per il suo contributo alla scienza ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui oltre 40 lauree honoris causa, il Premio Tyler per i risulta ti ambientali nel 1983, il Premio UNEPSasakawa per l'ambiente nel 1995, il Premio Nobel per la chimica nel 1995, la Medaglia presidenziale della libertà e il
Premio Terra delle Nazioni Unite.
Medaglia “Raffaella Rossi Manaresi”
Con la medaglia “Raffaella Rossi Manaresi” la Divisione di Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali della Società Chimica Italiana (da qui in avanti, "Divisione") intende conferire un riconoscimento a giovani studiosi di età inferiore a 40 anni, soci effettivi della Divisione da almeno 2 anni, che si siano già distinti per l‘eccellenza della loro attività di ricerca nel settore della Chimica dei Beni Culturali. La medaglia è assegnata in occasione del Congresso Divisionale.
Raffaella Rossi Manaresi (1924-2011) si è laureata in Chimica presso la Facoltà di Scienze Chimiche Fisiche e Naturali dell’Università di Bologna nel 1948. Cominciò la sua attività di ricercatrice in biochimica con il marito, prof. Carlo Alfonso Rossi, e la sua attività di chimico dei Beni Culturali in seguito alla alluvione di Firenze del 1966, dimostrando ben presto una instancabile passione e dedizione per l’applicazione delle scienze chimiche alla conservazione delle opere d’arte. Prestò la sua opera dapprima al Comune di Bologna e, in seguito, alla Soprintendenza alle Belle Arti di Bologna, dove i Soprintendenti Gnudi ed Emiliani vollero istituire il primo Laboratorio scientifico per la conservazione dei beni culturali. Erano anni pionieristici, nei quali Raffaella Rossi Manaresi dedicò i suoi studi alla conservazione della pietra e del mattone, come testimoniato dai Convegni internazionali del Centro per la conservazione delle Sculture all’aperto (di cui fu instancabile promotrice e curatrice dal 1969 fino alla fine degli anni ’80) e da numerosi lavori pubblicati su Studies in conservation. Suoi studi pionieristici sul trattamento della pietra con materiali polimerici hanno riguardato il protiro della Cattedrale di Ferrara, la facciata di San Petronio e le formelle di Jacopo della Quercia a Bologna, nonché le sculture del battistero di Parma. Di importanza primaria rivestono i suoi studi tecnici sulla scultura policroma romanica e gotica e gli studi sui trattamenti dei mattoni a vista. Divenne Direttrice del Laboratorio Scientifico della Fondazione Cesare Gnudi. Stabilì innumerevoli contatti scientifici internazionali e fu nominata Fellow dell’International Institute for Conservation (London, UK). Nel 1990, al Convegno Internazionale Lavas and Volcanic Tuff a Easter Islands, le fu attribuito un premio alla carriera.
Vincitori
Albo d’oro
Medaglia Meadows & Feller
-
2025 – Costanza Miliani (ISPC-CNR), la sua attività scientifica si distingue per l’approccio pionieristico alla diagnostica non invasiva dei beni culturali, che ha permesso di portare le scienze chimiche direttamente nei musei e nei siti storici, stabilendo nuovi paradigmi per l’interazione tra scienza e patrimonio culturale. La sua visione strategica, testimoniata anche dal ruolo di Direttrice dell’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC) del Consiglio Nazionale delle Ricerche – rappresenta un punto di riferimento per la nostra comunità scientifica, sia a livello nazionale che internazionale.
-
2024 – Rocco Mazzeo (Università di Bologna), per il suo fondamentale apporto scientifico e culturale a livello internazionale nel campo della diagnostica e dello sviluppo di nuovi materiali per la conservazione dei Beni Culturali. Il prof. Rocco Mazzeo ha, inoltre, fortemente sostenuto e sviluppato le collaborazioni tra l’ambiente accademico e gli enti preposti alla conservazione del patrimonio culturale.
-
2023 – Fabrizio Passarini (Università di Bologna), per la sua intensa attività di ricerca nel campo della Chimica dell’Ambiente e dei Culturali e per lo sviluppo di approcci innovativi per la valutazione degli impatti ambientali associati a processi chimici di interesse industriale, al ciclo ed alla gestione dei rifiuti fino alla sintesi di farmaci di largo consumo.
-
2022 – Antonio Marcomini (Università di Venezia), considerata la vastità dei suoi interessi di ricerca nel campo della chimica dell’ambiente e dei beni culturali
Medaglia Mario Molina
-
2025 – Luca Carena (Università di Torino), per la sua intensa attività nell’ambito dello studio di processi chimici e fotochimici in neve e ghiaccio e dei processi fotochimici abiotici in acque superficiali.
-
2024 – Luca Rivoira (Università di Torino), per il suo importante contributo nell’ambito delle tecniche per la riduzione degli impatti ambientali di inquinanti prioritari ed emergenti e per la loro caratterizzazione in diverse matrici ambientali.
-
2023 – Luca Ciacci (Università di Bologna), per il suo contributo innovativo alla valutazione dell’ impatto ambientale mediante analisi del ciclo di vita di processi di ampio interesse per la chimica ambientale.
-
2022 – Daniele Cespi (Università di Bologna), per il suo contributo innovativo alla valutazione di impatto ambientale dei processi industriali.
Medaglia Raffaella Rossi Manaresi
-
2025 – Non assegnata.
-
2024 – Giacomo Fiocco (Università di Pavia), per la sua intensa attività nell’ambito della diagnostica per i beni culturali e, in particolare, per l’importante contributo alla caratterizzazione e conservazione di beni musicali di notevole pregio.
-
2023 – Enrico Greco (Università di Trieste), per il suo contributo allo sviluppo di ricerche nell’ambito della conservazione del patrimonio culturale attraverso un approccio innovativo e inclusivo dei temi ambientali e per il respiro internazionale delle sue ricerche
-
2022 – Letizia Monico (CNR-Perugia), per il suo contributo allo studio della reattività chimica mediante tecniche spettroscopiche dei materiali dei beni culturali e in particolare di pigmenti di natura inorganica.




